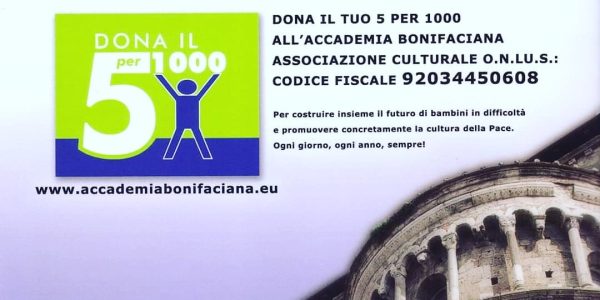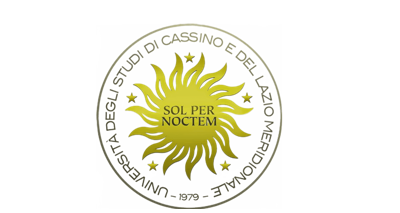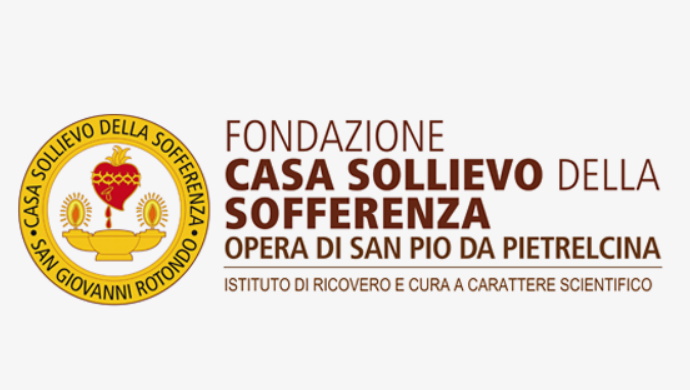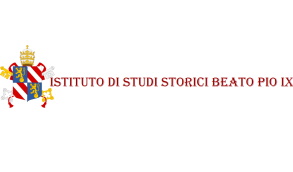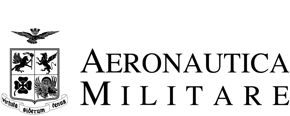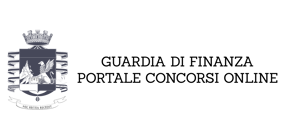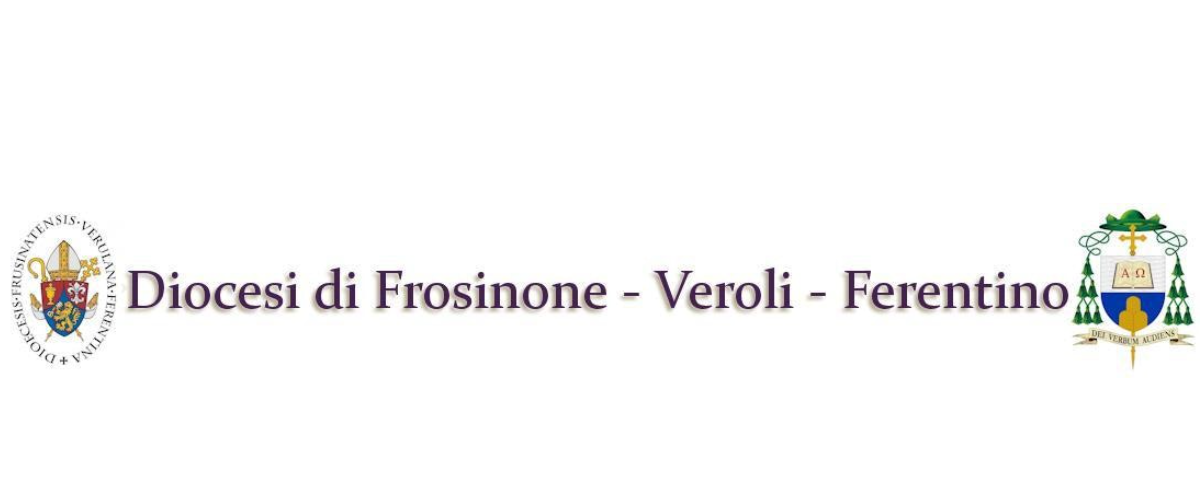Fede Scienza Virtù per una Cultura della Pace
Fede Scienza Virtù per una Cultura della Pace

Accademia Bonifaciana
La nascita dell’Associazione Culturale Onlus denominata “Accademia Bonifaciana”, che ha sede presso il Palazzo Papale di Bonifacio VIII, per gentile concessione della Congregazione delle Suore Cistercensi della Carità, che in quella sede hanno la Casa Generalizia ed il Premio Nazionale ed Internazionale “Bonifacio VIII” coincidono con il settecentesimo anniversario del famoso episodio, passato alla storia, come “Lo schiaffo di Anagni”, (7 settembre 1303) aventi come protagonisti il Pontefice anagnino Bonifacio VIII, ideatore del Primo Anno Santo della storia della Chiesa (1300) e della morte dello stesso Papa (11ottobre 1303).
DONA IL TUO 5 PER 1000
COME FARE? E’ SEMPLICISSIMO:
1. Individua il riquadro dedicato alla “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF nei modelli disponibili per la dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e modello UNICO per le persone fisiche)
2. Metti la tua firma nella casella “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (Onlus)
3. Riporta il codice fiscale dell’Associazione: 92034450608
Per costruire insieme e promuovere concretamente la cultura della Pace.
Ogni giorno, ogni anno, sempre!


 Fides Scientia Virtus Pro Pacis Cultu
Fides Scientia Virtus Pro Pacis Cultu